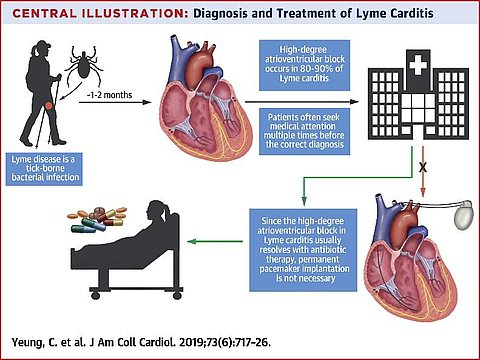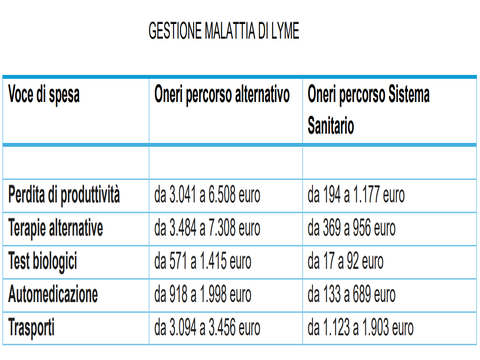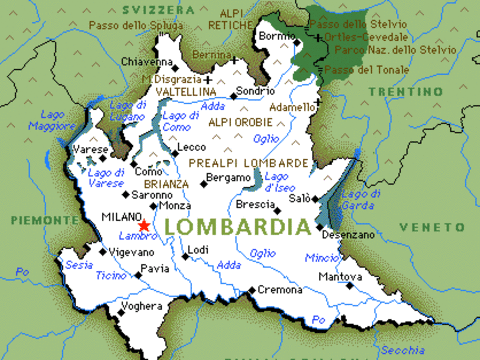Yoga e meditazione possono alleviare i sintomi della malattia di Lyme post trattamento (PTLDS)? Uno studio clinico del Centro di ricerca sulle malattie trasmesse dalle zecche del Columbia University Irving Medical Center di New York (USA) dimostra come possano agire positivamente nel ridurre i disturbi multisistemici, migliorando l’umore, il sonno, il fisico e le facoltà cognitive.
Lo studio analizza gli effetti del Kundalini Yoga, una “pratica contemplativa che integra movimento, respirazione e meditazione”, già impiegata nel trattamento di altre condizioni croniche con sintomi di affaticamento, dolore, disturbi del sonno, disagio psicologico, ansia e deterioramento cognitivo, comuni anche alla malattia di Lyme post trattamento (PTLDS).
I risultati
La ricerca presenta i benefici ottenuti dai 29 partecipanti che hanno seguito le 8 settimane di attività previste dal programma.
I dati raccolti evidenziano che le pratiche del Kundalini Yoga hanno prodotto benefici nella gestione del dolore, pur non potendolo risolvere e un “miglioramento significativo delle capacità cognitive” riferite a:
– memoria
– attenzione
– velocità di elaborazione conoscitiva.
Ha rilevato inoltre nei partecipanti:
– una sensibile attenuazione dei sintomi di “nebbia cerebrale”
– una riduzione del carico di sintomi persistenti
– una complessiva percezione di “sentirsi meglio”.
Il percorso seguito
I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi (di 4 o 6 persone), si sono incontrati una volta alla settimana per 8 settimane per completare sessioni di pratica Kundalini Yoga di un’ora e mezza ciascuna.
Le sessioni sono state condotte da un ricercatore medico e da un istruttore certificato.
Ogni partecipante ha inoltre completato a casa le attività, documentando ogni giorno la durata della pratica attuata, pari a circa 35 minuti.
Cosa segnala la ricerca
Lo studio della Columbia University contiene diversi elementi di novità.
È il primo a esplorare un intervento comportamentale quale supporto terapeutico nella gestione della malattia di Lyme persistente.
Descrive un intervento “sicuro, accessibile ed economico”, basato su yoga e meditazione, come “potenzialmente efficace nel ridurre alcuni dei sintomi principali” della PTLDS.
Dimostra che l’attività di gruppo può risultare coinvolgente e in grado di fornire un significativo sostegno psicologico, mentale ed emotivo ai partecipanti, aiutandoli a sviluppare resilienza alle difficoltà poste dal perseverare dei disturbi.
Indica la strada per ulteriori sperimentazioni cliniche su vasta scala, finalizzate a raccogliere informazioni e dati obiettivi sulla tipologia e l’entità dei possibili benefici associati alle pratiche meditative quale terapia complementare della malattia di Lyme post trattamento.
Per approfondire clicca qui
Fonte immagine: https//fitelo.co
Ci stiamo avvicinando rapidamente a Natale. A tutti coloro che ci seguono online rivolgiamo i nostri migliori auguri e la nostra gratitudine per la fiducia e il sostegno.
Grazie per averci stimolato con domande, commenti e condivisioni e per aver sostenuto un’informazione attendibile nel vasto (e periglioso) mondo di internet.
Grazie anche per aver dato vita ad una comunità virtuale sempre più consapevole dei rischi legati al morso di zecca, delle malattie che possono derivare, dell’importanza di usare la prevenzione come arma di difesa.
Ci prepariamo a salutare il 2023 con temperature quasi primaverili, segno evidente dei cambiamenti climatici in corso. Purtroppo giocano a favore delle zecche, rimaste in attività ma anche in questo periodo dell’anno.
Vi invitiamo a tenere alta la guardia per evitare infezioni insidiose, come la diffusa malattia di Lyme e potenzialmente molto serie, come la Tbe (encefalite da zecche).
Per il 2024 abbiamo in serbo nuovi progetti e continueremo a proporre articoli informativi, approfondimenti e risorse utili a conoscere i progressi e le direzioni in cui si muove la ricerca scientifica nel sempre più esteso campo delle malattie trasmesse da zecche.
A quanti vorranno condividere questo impegno diamo appuntamento all’8 gennaio.
A tutti l’augurio di un Felice Natale e di buon anno!
Maurizio Ruscio e i collaboratori del sito www.morsodizecca.it
Le zecche sono una “minaccia” anche d’inverno. Lo rivelano i ricercatori dell’università di Hannover che hanno analizzato l’attività delle zecche nei periodi invernali 2020-2021 e 2021-2022, documentando la loro ricerca dell’ospite anche nei mesi più freddi (da dicembre a febbraio).
I risultati delle indagini dimostrano che le zecche sono attive a temperature comprese fra -2,1°C e +16,5°C, soprattutto dopo giornate miti e senza vento.
Un rischio tutto l’anno
La ricerca pubblicata sul numero di novembre della rivista Ticks and tick-borne diseases (Zecche e malattie trasmesse dal morso di zecca) attribuisce ai cambiamenti climatici la prolungata attività delle zecche nella stagione invernale.
Prevede inoltre tre effetti causati da inverni sempre più miti:
– probabili infestazioni lungo tutto il corso dell’anno
– maggiori possibilità di incorrere nel morso di zecca
– rischi di malattia più elevati “per gli esseri umani e gli animali”.
Le più “aggressive”
Lo studio segnala fra le specie più attive nei mesi invernali:
– la comune zecca dei boschi (Ixodes ricinus), principale vettore della malattia di Lyme e della Tbe (encefalite da zecche)
– la sempre più diffusa zecca degli acquitrini (Dermacentor reticulatus), responsabile della trasmissione di vari agenti infettivi all’uomo e agli animali, tra cui la grave Babesiosi canina.
I rischi per gli animali da compagnia
I bersagli preferiti dalle zecche nel periodo invernale sono soprattutto cani e gatti abituati a frequentare ambienti esterni (giardini, parchi, boschi).
Stando ai dati raccolti dai 219 veterinari coinvolti nello studio:
– cani e gatti hanno dimostrato infestazioni continue di zecche durante l’inverno
– il tasso di infestazione nei cani è risultato maggiore rispetto ai gatti
– il mese più a rischio si è rivelato febbraio, con numeri crescenti di Ixodes ricinus e di Dermacentor reticulatus estratte dagli animali da compagnia.
Le indicazioni
I ricercatori “raccomandano fortemente” il regolare controllo delle zecche su canie gatti nei mesi invernali e una pulizia accurata di cucce e giacigli.
Consigliano inoltre di sentire il veterinario di fiducia per eventuali trattamenti acaricidi, da individuare in base alla zona, all’entità delle infestazioni e ai rischi di trasmissione di agenti infettivi.
Una minaccia anche per l’uomo
Lo studio segnala che da dicembre a febbraio il rischio zecche è probabilmente sottostimato dalla maggior parte delle persone.
Da qui l’invito a:
- usare le normali precauzioni tutto l’anno quale “necessaria” misura di protezione
- effettuare un’accurata ispezione del corpo, dei vestiti e delle attrezzature dopo attività, passeggiate ed escursioni in luoghi situati all’aperto.
Tra gli interventi raccomandati vi è anche l’informazione al pubblico sui rischi collegati al morso di zecca durante la stagione invernale.
Un invito che raccogliamo, invitando le persone a non abbassare la guardia in questo periodo dell’anno.
Per approfondire clicca qui
Fonte immagine:www.pexels.com
La malattia di Lyme colpisce le donne in forma più grave? A porre la domanda e segnalare la necessità di studi clinici mirati è un gruppo di ricerca americano che ha analizzato 2.170 pazienti con diagnosi di malattia, riscontrando un’alta percentuale di donne con sintomi più severi rispetto agli uomini.
Lo studio – pubblicato sull’International Journal of General Medicine – ha evidenziato anche un maggior rischio di malattia persistente nel genere femminile per l’elevata frequenza di:
– ritardi diagnostici
– diagnosi inappropriate
– tasso più alto di coinfezioni.
La fonte dei dati
Le informazioni relative ai 2.170 pazienti inclusi nella ricerca sono stati ricavati dal registro MyLymeData promosso e curato dall’Associazione LymeDisease.org.
Il registro è formato da auto-segnalazioni (anonimizzate) di pazienti riferite a:
– sintomi
– test diagnostici
– risposta al trattamento antibiotico
– effetti collaterali.
Il target di riferimento
Lo studio precisa che il campione analizzato è formato da 1839 donne e 331 uomini residenti negli Stati Uniti.
Data la prevalenza femminile la metodologia delle indagini ha seguito specifici criteri per un corretto confronto fra esperienze di malattia femminili e maschili.
I risultati
Lo studio ha messo in evidenza alcune caratteristiche comuni della borreliosi di Lyme fra uomini e donne:
– un rapporto sostanzialmente uguale di eruzioni cutanee (Eritema migrante)
– un riscontro simile di test di laboratorio positivi
– un’analoga risposta al trattamento antibiotico e agli effetti collaterali associati alla terapia.
La ricerca ha tuttavia segnalato nelle donne:
– un maggior tasso di coinfezioni trasmesse da zecche (81% di donne contro il 75% di uomini)
– un numero più elevato di diagnosi in fase avanzata (83% di donne contro il 76% di uomini)
– una significativa ricorrenza di diagnosi ritardate (il 36% di donne dichiara di aver consultato 10 o più medici prima della diagnosi contro il 25% di uomini)
– una più alta frequenza di diagnosi inappropriate (80% di donne contro il 71% di uomini).
La rilevanza dei sintomi
Le donne hanno inoltre riferito una maggiore severità di cinque sintomi di Lyme:
– affaticamento
– dolori muscolari e articolari
– disturbi del sonno
– manifestazioni gastrointestinali
– mal di testa.
Hanno dichiarato inoltre forme più gravi di neuropatia e perdita di memoria.
Per contro una percentuale più elevata di uomini ha riportato deterioramento cognitivo e manifestazioni cardiache.
L’indicazione
Poiché l’indagine si riferisce a un campione “non rappresentativo dell’intero spettro di pazienti con Lyme” i ricercatori hanno evidenziato la necessità di ottenere, da futuri studi clinici, dati differenziati per genere sulle manifestazioni della malattia e sui sintomi persistenti.
Tali informazioni serviranno a comprendere se, e in che misura, le variabili biologiche svolgono un ruolo nell’evoluzione della malattia e ottenere quindi “informazioni scientifiche utili a tutti i pazienti”.
Per approfondire clicca qui
Uno studio congiunto delle università di Harvard (USA) e di Montréal (Canada) ha utilizzato Twitter come strumento di sorveglianza della malattia di Lyme negli Stati Uniti. L’analisi – pubblicata lo scorso 16 ottobre sulla rivista scientifica BMC Medical Informatics and Decision Making – ha rilevato una “correlazione abbastanza forte” fra numero dei tweet e dati ufficiali sui casi di malattia, mettendo anche in evidenza il contributo della piattaforma social nel “diffondere la consapevolezza popolare sulla malattia di Lyme”.
In pratica le abitudini di tweeting si sono rivelate un “termometro” affidabile sulla diffusione e l’incidenza dell’infezione, oltre che un inedito quanto promettente indicatore epidemiologico.
Perché Twitter?
La scelta del popolare social network è dovuta al fatto che conta 76,9 milioni di iscritti e colloca gli Stati Uniti in testa ai paesi con il maggior numero di utenti.
Ogni giorno la piattaforma registra 500 milioni di tweet in tempo reale, per lo più pubblici e geolocalizzati in modo specifico.
Permette quindi di avere accesso a un ampio e aggiornato set di dati e di poterli analizzare in modo dettagliato.
Come si è svolto lo studio
La ricerca si è articolata in tre fasi:
– nella prima sono stati raccolti circa 1,3 milioni di tweet in lingua inglese, pubblicati tra il 2010 e il 2019, poi rielaborati per estrarre quelli più rilevanti sulla malattia di Lyme
– il procedimento ha consentito di ottenere un set di 77.500 tweet utilizzato per addestrare, convalidare e testare un modello di classificazione dei tweet più pertinenti
– i risultati ottenuti sono stati quindi confrontati con i dati ufficiali disponibili per la malattia di Lyme.
Il raffronto ha:
– confermato una stretta correlazione tra tweet e casi di malattia soprattutto nel 2017, 2018 e 2019
– sottolineato il ruolo svolto da Twitter nel 2015 e 2016 per far aumentare la consapevolezza generale sulla malattia di Lyme
Il precedente inglese
Un analogo studio – pubblicato nel 2019 sul Journal of Biomedical Informatics – è stato condotto in Gran Bretagna e Irlanda tra il 1 luglio 2017 e il 30 giugno 2018.
L’analisi dei 13.757 tweet raccolti ha permesso di:
– individuare 5.212 utenti geolocalizzati nel Regno Unito e nella Repubblica di Irlanda
– trovare una corrispondenza tra i tweet sulla malattia di Lyme e i rapporti di sorveglianza nazionale
– considerare Twitter una piattaforma dotata di un elevato potenziale per scoprire precocemente focolai di malattia.
Qual è il valore dei dati digitali?
I livelli di “rumore” dei social media si stanno rivelando un campo di indagine che attira l’interesse dei ricercatori per la potenziale capacità di fornire, in modo rapido ed economico, indizi e segnalazioni geograficamente identificate sul sorgere o l’espandersi delle malattie.
Il fenomeno, noto come epidemiologia digitale, non è tuttavia privo di rischi.
L’utilizzo di dati provenienti dai social media rappresenta infatti una sfida sul piano dell’accuratezza, ma soprattutto su quello della privacy.
Tuttavia i comportamenti on line delle persone che utilizzano il web per esprimere le loro preoccupazioni, segnalare il loro stato di salute, cercare informazioni su sintomi e rimedi possono rivelarsi un nuovo, quanto interessante strumento di allerta precoce e monitoraggio delle malattie.
Per approfondire clicca qui
fonte: www.pexels.com
Fonte immagine: https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-023-02315-z#Tab1
Circa il 10% dei pazienti di Lyme non guarisce dopo le cure e sviluppa la cosiddetta Sindrome post trattamento o PTLDS (Post Treatment Lyme Disease Syndrome) con affaticamento, dolore muscolo-scheletrico, difficoltà cognitive che perdurano nel tempo. Poiché si tratta di sintomi comuni anche ad altre forme morbose, la diagnosi di PTLDS rappresenta una sfida e deve escludere la possibilità di altre malattie.
Lo sottolinea uno studio delle università francesi di Clermont Auvergne e Saint-Étienne (pubblicato lo scorso ottobre su BMC Infectious Diseases) che approfondisce le conseguenze e gli eventi avversi associati a diagnosi improprie.
Cosa dice lo studio
I ricercatori francesi hanno analizzato gli effetti causati da errori diagnostici e trattamenti non autorizzati di PTLDS, contenuti in studi e report clinici pubblicati tra il 1 gennaio 2010 e il 5 novembre 2020 in riviste e database internazionali.
La lettura dei dati fa emergere un alto numero di errate diagnosi, responsabili di ritardi nel riconoscimento di varie malattie, tra cui:
– malattie oncologiche (tumore ipofisario, Linfoma di Hodgkin, cancro ai polmoni),
– malattie neurodegenerative (Parkinson, Sclerosi laterale amiotrofica-SLA, demenza frontotemporale),
– malattie neuropsichiatriche (depressione, stress post-traumatico, ansia cronica, decadimento delle risorse psicofisiche),
– malattie reumatologiche (a carico del sistema muscolo-scheletrico)
con esposizione dei pazienti a “sofferenze prolungate e alla mancata opportunità di gestire tali malattie in forma adeguata”.
Lo studio segnala inoltre che gli errori diagnostici hanno determinato trattamenti antinfettivi non necessari, causando ai pazienti:
– complicazioni gastrointestinali,
– infezioni batteriche e fungine,
– reazioni anafilattiche,
– fenomeni di resistenza agli antibiotici.
Un insieme di effetti collaterali potenzialmente gravi, talora responsabili di ricoveri ospedalieri e conseguenze a lungo termine.
Il richiamo alle responsabilità
Per i ricercatori francesi “i pazienti con PTLDS provano spesso una sensazione di non riconoscimento e di abbandono da parte dei medici”. Di conseguenza “consultano informalmente sanitari che raccomandano test non certificati (…) e terapie non approvate”.
Da qui il richiamo a due ordini di responsabilità:
– la prima di natura etica, legata al dovere del medico di non causare al paziente “danni prevenibili”,
– l’altra di natura professionale, finalizzata a instaurare un efficace dialogo medico-paziente su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza o inadeguatezza, così da promuovere scelte consapevoli e possibilmente condivise.
La raccomandazione
Lo studio evidenzia che i mancati approfondimenti diagnostici, combinati all’uso di test non standardizzati e non raccomandati e alla mancanza di criteri diagnostici riconosciuti, può determinare:
– un’elevata sovra-diagnosi di Sindrome post trattamento di malattia di Lyme
– un conseguente ricorso a trattamenti con efficacia non dimostrata e potenzialmente forieri di eventi avversi
– ritardi nella diagnosi di malattie a elevata morbilità.
I suggerimenti
Lo studio conclude con l’invito a valutare attentamente i casi di PTLDS e richiama i medici all’imperativo etico del “primum non nocere” (non nuocere al paziente).
Per approfondire clicca qui
Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) statunitense ha recentemente inserito l’encefalite da zecche (Tbe) tra i rischi per i viaggiatori americani che si recano in Europa e in Asia. Tra le destinazioni con rischio noto o possibile di Tbe c’è anche l’Italia, in particolare i territori del Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia).
Due le raccomandazioni fornite: evitare i morsi di zecca e sottoporsi preventivamente alla vaccinazione anti-Tbe se:
– l’itinerario di viaggio e le attività programmate comprendono zone boschive o rurali situate in aree endemiche,
– la durata del viaggio comporta una frequente o regolare possibilità di esposizione ai morsi di zecca,
– gli spostamenti avvengono da aprile a novembre, ovvero nei mesi un cui si verifica la maggior parte dei casi di malattia.
Effetti e conseguenze
Il CDC avverte che non esistono cure specifiche per l’encefalite da zecche, ma solo trattamenti di supporto.
Precisa inoltre che la Tbe può:
– presentarsi in forma lieve ed esprimersi solo con febbre
– avere “un decorso monofasico o bifasico (cioè, una sola malattia neurologica isolata o una malattia neurologica dopo una malattia iniziale non specifica)”
– causare sintomi neurologici di diversa entità e comprendere: “stato mentale alterato, disfunzione cognitiva (diminuzione della concentrazione e disturbi della memoria), atassia, rigidità, tremori e paresi o paralisi dei nervi cranici e degli arti”, colpendo più spesso gli arti superiori di quelli inferiori
– comportare deficit neurologici anche gravi e lunghi tempi di recupero
– manifestare forme più gravi dopo i 60 anni (con ricoveri ospedalieri più lunghi, tassi di moralità più elevati, maggiori rischi di sequele, miglioramenti più lenti e non sempre completi).
Dagli USA al Regno Unito
A fine ottobre anche le autorità sanitarie inglesi hanno allertato i cittadini britannici sui rischi collegati all’encefalite da zecche.
Tra i consigli diffusi dal National Travel Health Network and Center (NaTHNaC) vi è la vaccinazione anti-Tbe per i viaggiatori del Regno Unito diretti in “aree colpite” dal virus della Tbe, la cui circolazione è riportata in:
Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Giappone, Kazakistan, Kosovo, Kirghizistan, Lettonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Paesi Bassi, Corea del Nord, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Romania, Russia (Federazione Russa), Serbia, Slovacchia, Svezia, Ucraina e nello stesso Regno Unito.
La segnalazione in Italia
Per l’Italia, l’Agenzia inglese di sicurezza sanitaria (Health Security Agency) segnala la presenza dell’encefalite da zecche in sei regioni:
– Emilia-Romagna
– Friuli Venezia Giulia
– Lazio
– Puglia
– Trentino-Alto Adige
– Veneto.
Indica quali ambienti a rischio le foreste, i boschi, i prati e i parchi urbani e come categorie frequentemente esposte ai morsi di zecca e alla possibilità di malattia: i lavoratori agricolo-forestali, i campeggiatori, gli escursioni e i cacciatori.
fonte immagine: https://www.cdc.gov/tick-borne-encephalitis/geographic-distribution/index.html
Ci sono strumenti di intelligenza artificiale (AI) progettati per dare informazioni e rispondere a domande di ogni tipo, anche di carattere medico. Tecnicamente sono dei chatbot, ovvero dei software capaci di interagire con le persone in modo simile a quanto avviene fra persone reali. Uno dei più noti è ChatGPT e Lyme Project, un’organizzazione americana no-profit, lo ha testato per verificare quanto sa della malattia di Lyme, mettendolo a confronto con un analogo strumento di Google, chiamato Google Bard.
Ai due chatbot è stato sottoposto un questionario con 7 domande sul morso di zecca e le sue conseguenze, i sintomi della malattia di Lyme, i test diagnostici, le cure e la durata dei trattamenti.
Le risposte
Tanto ChatGPT quanto Google Bard hanno dimostrato di “possedere le nozioni di base sulla malattia di Lyme e su altre malattie trasmesse dalle zecche”, ma di non essere in grado di:
– proporre indicazioni approfondite e complete
– fornire risposte dettagliate e articolate come farebbe un medico.
Cosa ha rivelato il test
L’esperimento ha dimostrato che gli strumenti di intelligenza artificiale non si possono considerare:
– “medici virtuali”
– fonti affidabili per ottenere una diagnosi e indicazioni sulle terapie.
Il loro utilizzo si limita a un contributo per “diffondere la consapevolezza e offrire un’educazione fondamentale sulla malattia di Lyme e su altre malattie trasmesse dalle zecche”.
La versione italiana
Di ChatGPT esiste una versione italiana: si chiama PizzaGPT, sviluppata da Lorenzo Cella, un ingegnere (italiano) che lavora in Svizzera.
Messo alla prova il chatbot nazionale (che adopera l’interfaccia di programmazione dell’applicazione di ChatGPT) ha dichiarato:
– sono un modello di intelligenza artificiale generativa, addestrato su una vasta quantità di dati, ma non sono in grado di verificare direttamente le informazioni né di confermare se le notizie sono vere o false
– potrei anche rispondere a una domanda con informazioni inesatte.
Il rinvio al medico reale
Interpellato sulla malattia di Lyme anche PizzaGPT ha fornito risposte di base sostanzialmente corrette, corredate però da questi avvisi:
– “si consiglia di consultare un medico se si sospetta di aver contratto la malattia di Lyme o altre malattie trasmesse dalle zecche”
– “è importante rivolgersi a un medico per una valutazione accurata e per ricevere eventuali trattamenti”.
Qual è dunque il messaggio?
Gli strumenti di intelligenza artificiale “sono ancora imperfetti” per stessa ammissione dei loro sviluppatori.
Nel caso della malattia di Lyme – ma il discorso vale per ogni quesito di salute – possono dare indicazioni generali anche corrette, ma non sono in grado di fornire:
– una diagnosi
– un responso medicoattendibile
– una consulenza verificata,approfondita e personalizzata.
Quando si consultano va sempre considerato il rischio di incorrere in informazioni imprecise, inappropriate o addirittura errate e fuorvianti.
Per approfondire clicca qui
Individuare l’agente responsabile della malattia di Lyme in un campione di sangue è una prova certa dell’infezione e consente una diagnosi sicura. Tra i metodi disponibili c’è la microscopia in campo oscuro. Perché non viene utilizzata di routine?
I motivi sono essenzialmente tre:
– la concentrazione dei batteri di Lyme nel sangue è molto bassa e si riduce drasticamente dopo il prelievo
– il campione dev’essere raccolto e gestito con procedure molto rigorose per essere idoneo all’esame e risultare privo di contaminazioni, anche ambientali, che potrebbero falsare il risultato
– l’osservazione al microscopio è svolta da un operatore e comporta una valutazione soggettiva, non standardizzabile, con possibilità di errore anche per l’occhio più allenato.
Cosa dice la ricerca scientifica
Uno studio pubblicato ad agosto 2023 riporta una tecnica di osservazione microscopica in campo oscuro modificata, in grado di rilevare la struttura dei batteri di Lyme nel sangue. Messa tuttavia alla prova, ha dato risultati deludenti:
– ha infatti riconosciuto l’esistenza della malattia solo nel 66% dei pazienti effettivamente colpiti dall’infezione
– ha classificato come malati ben l’85% dei sani che hanno partecipato alle prove di controllo.
Lo studio conclude che l’esame microscopico in campo oscuro è “inadatto per la diagnosi della malattia di Lyme” a causa della bassa specificità (capacità di individuare i soggetti sani) e del numero elevato di risultati falsamente positivi. Ritiene quindi che l’esame vada considerato solo per scopi di ricerca.
Il metodo DualDur
La società ungherese Lyme Diagnostics Ltd ha ottenuto dall’Unione Europea un contributo di 3.507.750 euro per migliorare la microscopia in campo oscuro e testare un sistema automatizzato, indicato come «metodo DualDur», in grado di:
– dare stabilità ai campioni di sangue e rilevare i batteri di Lyme anche a minime concentrazioni
– utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) per individuare al microscopio gli agenti infettivi, così da ridurre al minimo l’errore umano.
Nel sito della UE dedicato alla ricercanon sono tuttavia pubblicati i risultati della sperimentazione e non sono disponibili dati o documenti sulla validazione dell’innovativo test.
Cosa sappiamo
Neanche il sito della Lyme Diagnostics Ltd riporta gli esiti della sperimentazione condotta con il DualDur.
La società menziona solo i centri dove si è svolta, precisando “I risultati dettagliati saranno pubblicati in un articolo scientifico”, a tutt’oggi assente.
Ulteriori ricerche sui dettagli dello studio effettuate con PubMed – noto database internazionale di articoli scientifici e medici – segnalano:
– “i risultati dello studio non sono stati presentati
– nessuna pubblicazione disponibile”.
Non sorprende quindi se la società ungherese afferma: nella «microscopia automatizzata in campo oscuro DualDur […] la valutazione viene eseguita digitalmente da un software, ma i risultati hanno valore diagnostico solo dopo la convalida umana».
Qualche dubbio
Come si convalida il risultato di un test di cui non sono note le verifiche sui parametri delle prestazioni?
Le strade percorribili sono essenzialmente due:
– la ripetizione manuale dell’esame, con l’inevitabile possibilità di errore
– l’esecuzione di prove di controllo, utilizzando i test attuali.
Qual è l’utilità della microscopia in campo oscuro?
La risposta è data con chiarezza dalla Lyme Diagnostics: anche sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale la diagnosi (di malattia di Lyme) con la microscopia in campo oscuro vale «come metodo complementare».
Sembra quindi confermata l’indicazione della ricerca scientifica: nella malattia di Lyme i risultati attuali dell’osservazione microscopica in campo oscuro non garantiscono una diagnosi certa e vanno interpretati con cautela per l’eventualità, tutt’altro che remota, di un numero elevato di falsi positivi.
Per approfondire clicca qui
fonte immagine Pixabay