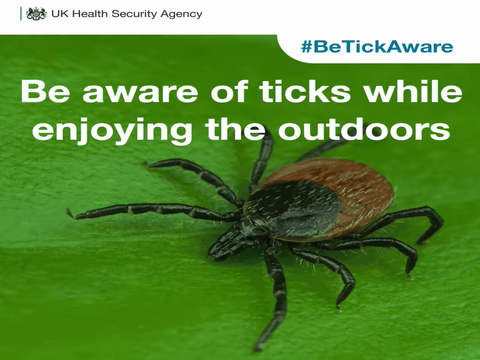Lo sviluppo del candidato vaccino contro la malattia di Lyme subisce una brusca frenata. Le due aziende produttrici, Pfizer e Valneva, hanno deciso di interrompere la terza fase di sperimentazione clinica in alcuni centri, dopo aver accertato «violazioni degli standard di buona pratica clinica» da parte di un operatore terzo (non precisato).
La decisione riguarda la metà circa dei volontari arruolati negli Stati Uniti e, secondo le stime, coinvolge 2.000 persone.
L’avanzamento della sperimentazione
L’avvio dell’ultima fase di sperimentazione clinica era stata annunciata da Pfizer e Valneva nell’agosto 2022, con previsione di includere circa 6.000 partecipanti dai 5 anni in su, reclutati negli Usa e in Europa dove la malattia di Lyme è endemica.
Doveva testare l’efficacia, la sicurezza e l’immunogenicità del vaccino su larga scala, verificando che tutti i risultati dei test rispondessero agli standard internazionali di qualità etica e scientifica.
Si tratta di standard «progettati per mettere al primo posto gli interessi dei partecipanti e garantire un’elevata integrità scientifica dei risultati raccolti».
Gli effetti della interruzione
A parere degli analisti difficilmente il nuovo vaccino sarà disponibile nei tempi indicati da Pfizer lo scorso anno, quando l’azienda aveva anticipato la possibilità di presentare nel 2025:
– una domanda di licenza biologica alla Food and Drug Administration (FDA) americana,
– l’autorizzazione all’immissione in commercio all’Agenzia europea per i farmaci.
Tutto dipende dalle autorità di regolamentazione sanitaria: se non accetteranno i dati della metà dei partecipanti esiste un rischio concreto di ritardi, ipotizzati in un anno o più.
Le rassicurazioni
Pfizer ha dichiarato l’intenzione di salvaguardare le tempistiche sul vaccino anticipando che «collaborerà con le autorità di regolamentazione per introdurre eventuali modifiche al processo di sperimentazione».
Ha anticipato inoltre che la sperimentazione stessa continuerà in altri centri, non gestiti da terzi, presso i quali sta arruolando nuovi volontari.
Per approfondire clicca qui
La malattia di Lyme tiene l’attrice Delia Montebello lontana dalle scene e la costringe a un «duro» percorso di riabilitazione.
È la stessa attrice a raccontare in una intervista di qualche giorno fa l’esordio subdolo della malattia, le difficoltà incontrate nella diagnosi, i ricoveri in ospedale e i lenti segnali di ripresa.
Due mesi fa i primi sintomi
La storia della Montebello inizia a dicembre.
Mentre è in ospedale, a Ortona, per accertamenti di routine, un’infermiera nota che ha un occhio «appesantito» e la invita a farsi visitare in pronto soccorso.
L’attrice pensa sia la conseguenza di un colpo d’aria, ma segue il consiglio. Le viene prescritto un farmaco e l’indomani ha tutto il viso gonfio.
Si rivolge al reparto di emergenza di Pescara e viene ricoverata in otorinolaringoiatria.
La prima diagnosi
Il responso dei medici è «Paresi di Bell», ma le cure non hanno effetto.
La paralisi le altera il viso: la distorsione della bocca «arriva fino all’orecchio», ha difficoltà a parlare e l’occhio destro non si chiude.
«Stavo sempre peggio – racconta l’attrice – e nessuno capiva cosa avessi realmente».
La scoperta della malattia
A intuire la possibile causa dei disturbi è un giovane medico. Le chiede se ha subìto qualche puntura di insetto e la Montebello ricorda di essere stata «pizzicata» da una zecca ad agosto.
L’informazione permette finalmente di arrivare alla diagnosi di borreliosi di Lyme. Segue il trasferimento al reparto malattie tropicali e l’inizio di un impegnativo ciclo di cure.
I progressi a piccoli passi
Dopo un mese di terapia arrivano i primi miglioramenti.
«Ora riesco a parlare – dichiara l’attrice – ma ho difficoltà con la pronuncia delle parole, la mia voce non è la stessa di prima, mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Una fisioterapista e una logopedista bravissime mi stanno rimettendo in sesto. È un percorso che dovrebbe portare alla guarigione completa ma la strada è ancora tortuosa».
Un caso emblematico
La paralisi di Bell diagnosticata a Delia Montebello è un segno frequente della malattia di Lyme, quando colpisce il sistema nervoso (neuroborreliosi).
Nel caso dell’attrice il collegamento fra la sua presentazione e il morso di zecca ha permesso di orientare la diagnosi e di individuare il trattamento corretto.
All’attrice auguriamo una veloce ripresa e di poter realizzare il progetto annunciato nell’intervista: trasformare la sua storia in una pièce teatrale e festeggiare il ritorno sulle scene interpretando se stessa.
Le dichiarazioni di Delia Montebello
Nei parchi urbani “i contatti con zecche infette possono essere più frequenti che altrove, a causa dell’elevata attività umana”.
A sostenerlo è una ricerca inglese, pubblicata il 4 febbraio sulla rivista internazionale Zoonoses and Public Heath, che sintetizza i risultati di oltre 100 pubblicazioni sulla diffusione dell’Ixodes ricinus (la comune zecca dei boschi) nelle aree verdi di 24 paesi europei, Italia compresa.
Un’insidia da non sottovalutare
Lo studio segnala a livello europeo una presenza media di 6,9 esemplari di zecca ogni 100 metri quadri di verde cittadino e una prevalenza di zecche infette da Borrelia, agente della malattia di Lyme, pari al 17,3%.
Sottolinea quindi l’importanza di adottare misure individuali di prevenzione durante la frequentazione di parchi, prati, giardini botanici e aree ricreative urbane e suburbane per il potenziale rischio di subire un morso di zecca e di incorrere in una puntura infettante.
L’arrivo delle zecche in città
La ricerca evidenzia che da oltre 30 anni è nota la presenza di zecche negli spazi verdi urbani, un fenomeno oggi in aumento ed esteso a numerosi habitat:
– dai parchi cittadini,
– alle aree verdi di quartiere,
– ai luoghi all’aperto con strutture sportive e di gioco.
Le zecche arrivano nelle città trasportate dagli uccelli e dai vari animali selvatici, sempre più spesso attirati nei centri abitati dalla disponibilità di cibo e di luoghi dove rifugiarsi.
Le aree verdi a basso rischio
Lo studio indica come zone a basso rischio le aree verdi urbane situate in posizione centrale, circondate da costruzioni e prive di collegamenti con ambienti rurali e naturali.
“In questi luoghi – sottolinea la ricerca – è possibile che la mancanza di fauna selvatica (probabilmente a causa della scarsa connettività con territori rurali) e l’adozione di pratiche di gestione del verde come il taglio regolare dell’erba e l’asportazione del fogliame, abbiano un impatto negativo sulla sopravvivenza delle zecche”.
Per approfondire clicca qui
La maggior parte delle persone con malattia di Lyme guarisce completamente dopo la terapia antibiotica. Una minoranza continua tuttavia riferire affaticamento, dolore ai muscoli e alle articolazioni, difficoltà cognitive, problemi di memoria e di attenzione, disturbi del sonno.
Quando i sintomi persistono per più di 6 mesi e limitano la vita quotidiana vengono spesso indicati come malattia di Lyme post trattamento o «PTLDS» (Post-Treatment Lyme Disease Syndrome).
I quesiti aperti
Della PTLDS si sa ancora poco:
– non si conoscono le cause e i fattori scatenanti
– mancano test di laboratorio e criteri standard per la diagnosi
– presenta sintomi descritti anche in altre infezioni post-acute, diverse e distinte dalla malattia di Lyme
– non ha protocolli di terapia convalidati ed è controverso l’uso prolungato di antibiotici.
Di conseguenza i pazienti riferiscono di sentirsi trascurati dalla comunità medico-scientifica per l’impossibilità di avere risposta ai loro problemi di salute.
Le ipotesi
L’origine della PTLDS è stata finora spiegata come effetto di tre possibili situazioni:
– una disfunzione del sistema immunitario, innestata dalla malattia di Lyme o dal battere che ne è responsabile (la Borrelia burgdorferi)
– un insuccesso della terapia, dovuto alla presenza di co-infezioni o alla capacità della Borrelia di eludere l’azione degli antibiotici con meccanismi non ancora chiariti
– una patologia diversa e distinta dalla malattia di Lyme in persone positive ai test per la Borrelia.
Gli sforzi per fare chiarezza
Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno cercato di monitorare la diffusione dei sintomi persistenti.
Due, in particolare, realizzati nei Paesi Bassi e in Belgio hanno rilevato che stanchezza, dolore e disturbi cognitivi persistenti per più di 6 mesi:
– sono comuni anche nella popolazione in generale
– risultano più frequenti e marcati nei pazienti con malattia di Lyme, ma in percentuali contenute.
Precedenti indagini hanno scoperto che i sintomi persistenti si verificano con maggiore frequenza tra i pazienti con malattia di Lyme più grave e ritardi nel trattamento.
Le indicazioni
I sintomi persistenti e debilitanti della PTLDS costituiscono un “promemoria” sull’urgente necessità di:
– promuovere l’avanzamento delle ricerche sulle cause della sindrome e sugli eventuali fattori di rischio
– sviluppare metodi diagnostici standardizzati
– individuare e convalidare adeguati percorsi di cura.
Segnalano inoltre l’importanza della prevenzione, incoraggiando le persone ad adottare comportamenti quotidiani per evitare i morsi di zecca.
L’Università del Maryland (USA) svela i misteri sull’immunità delle zecche e spiega come neutralizzano i batteri responsabili della malattia di Lyme (Borrelia burgorferi).
La scoperta è stata pubblicata lo scorso 13 gennaio sulla rivista Science e apre la strada a nuove potenziali strategie di prevenzione nei confronti della malattia di Lyme e di altre infezioni trasmesse dalle zecche.
La scoperta
I ricercatori hanno dimostrato che quando le zecche si nutrono su topi infetti riconoscono nel sangue dei topi particolari molecole, le citochine, le quali rivelano la presenza dell’agente infettivo.
Le zecche utilizzano le citochine dei topi come «segnalazione» e prima ancora di essere infettate si preparano a reagire in due modi: sviluppandosi rapidamente e attivando subito una efficace difesa immunitaria.
Il meccanismo
Con il rapido sviluppo le zecche consumano i nutrienti contenuti nel sangue dei topi prima che i nutrienti stessi arrivino ai batteri, così da indebolirli e pregiudicare la loro crescita. In questo modo le zecche infette crescono più rapidamente delle altre.
Mettendo subito in azione il proprio sistema immunitario innescano contemporaneamente una difesa precoce e mirata contro i batteri, annullando la loro capacità infettiva.
Le ricadute
La scoperta del meccanismo con cui le zecche rilevano la presenza dell’agente patogeno nel sangue dell’ospite e attivano il proprio sistema immunitario prima di essere infettate:
– spiega la capacità delle zecche di essere vettori efficienti di malattia
– apre la porta allo sviluppo di nuovi approcci e trattamenti per prevenzione della borreliosi di Lyme e delle coinfezioni.
Per approfondire clicca qui
Foto di Utpal Pal, Università del Maryland
Nei giorni scorsi l’azienda sanitaria provinciale di Trento ha rinnovato l’appello alla vaccinazione contro l’encefalite da zecche (Tbe), indicando gennaio e febbraio come i mesi più adatti per intraprendere il ciclo vaccinale.
L’invito è stato ribadito dal Dipartimento di prevenzione dopo il caso mortale registrato a inizio anno.
Due morti in 6 mesi
Il decesso di gennaio 2023 segue di pochi mesi un altro caso mortale per Tbe, verificatosi in provincia di Trento nel luglio dello scorso anno.
I due episodi sono stati interpretati come segnale di “un sostanziale aumento delle zecche infette nel territorio provinciale”. Da qui l’invito dell’azienda sanitaria a effettuare la vaccinazione per tempo, senza attendere le prime passeggiate.
I casi di Tbe in Trentino
“Negli ultimi tre o quattro anni il Trentino ha avuto un trend di 30/40 casi di Tbe all’anno, nella quasi totalità senza evoluzioni mortali”.
Il rischio però è alto e l’Azienda sanitaria invita a prevenire la malattia effettuando la vaccinazione proprio in questi primi mesi.
Il ciclo vaccinale – ricorda l’Unità operativa di igiene e sanità pubblica – consiste in tre dosi da fare nel corso di 12 mesi. Le prime due dosi vanno distanziate di almeno un mese l’una dall’altra.La successiva di almeno sette mesi.
Poiché una protezione sufficiente inizia a partire dalla seconda dose il periodo più indicato per iniziare la vaccinazione contro l’encefalite da zecca è tra gennaio e febbraio.
In questo modo è possibile effettuare la seconda dose a marzo ed avere, quindi, con l’arrivo della bella stagione una protezione adeguata.
Le aree a rischio
I primi casi di zecche infette da Tbe-virus si sono registrati in Trentino già nel 1992, interessando il territorio di Terlago,Stravino e Calavino.
A seguire sono state trovate in Val di Non e nella Val di Cembra.
Non risultano invece presenti a nel Trentino meridionale, anche se qualche anno fa è stato accertato un caso nell’Alto Garda.
Per approfondire clicca qui
Oltre a trasmettere batteri, virus e altri agenti infettivi il morso di zecca può causare un’allergia alla carne “rossa” chiamata sindrome di alfa-gal (o alpha-gal).
Provoca reazioni allergiche da lievi a gravi e recentemente ha attirato l’attenzione dei ricercatori per la sua diffusione non solo fra gli adulti ma anche fra bambini e ragazzi.
Come si scatena l’allergia
A causare l’allergia è uno zucchero, l’alfa-gal (galattosio-alfa-1,3), trasmesso dal morso di una zecca.
Stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici (le immunoglobuline E o IgE) e quanti vengono sensibilizzati sviluppano l’allergia dopo aver mangiato carni rosse che lo contengono (vitello, manzo, maiale, agnello, capra, cavallo).
Poiché l’alfa-gal è presente in vari prodotti e sottoprodotti industriali l’allergia può essere innescata anche da:
– altri alimenti di origine animale, come latticini e gelatine (compresa la gelatina contenuta in salse, marshmallow, caramelle, addensanti per yogurt, ecc.)
– diversi farmaci.
L’alfa-gal si trova anche nella carragenina, una gelatina molto usata in ambito alimentare, identificata nelle etichette con la sigla E407.
Perché è un’allergia diversa dalle altre
La reazione allergica non si manifesta subito dopo l’assunzione di carne rossa o di alimenti con l’alfa-gal ma si presenta a distanza di alcune ore (da 3 a 6 ore dopo), con sintomi di diversa gravità.
Le manifestazioni allergiche possono variare da soggetto a soggetto e comprendono:
– Orticaria, prurito
– Gonfiore delle labbra, del viso, della lingua e della gola o di altre parti del corpo
– Respiro sibilante o affannoso
– Mal di stomaco, crampi addominali, diarrea, vomito.
Può comparire anche un forte calo della pressione sanguigna e, nei casi più gravi, shock anafilattico.
Quando e dove sospettare l’allergia
La prima reazione allergica di solito si presenta in estate o in autunno, ovvero quando le zecche sono più attive nella ricerca di un ospite sul quale nutrirsi.
La maggior incidenza dei casi si verifica nelle zone dove la presenza delle zecche è endemica (in particolare dove è nota la diffusione dell’ Ixodes ricinus, la comune zecca dei boschi).
La diagnosi si basa sulla storia clinica e sui test che accertano la positività nel sangue delle IgE-α-gal.
Cosa fare dopo la diagnosi
Quando l’allergia è accertata occorre escludere dalla dieta le carni rosse e i loro derivati, i grassi come lardo, i brodi pronti e la gelatina.
Vanno anche evitati ulteriori morsi di zecca perché:
– possono aumentare il rischio di reazioni allergiche anche ad alimenti prima tollerati
– l’allergia può avere manifestazioni più importanti in caso di morsi ripetuti.
Per approfondire clicca qui
La saliva delle zecche blocca le difese immunitarie della pelle, aumentando così il rischio di malattie.
La scoperta è di un gruppo di ricercatori dell’Università di Vienna impegnati a studiare i meccanismi di alimentazione delle zecche e le conseguenze nella trasmissione di batteri, virus e altri agenti infettivi.
Gli studi sulla saliva
I ricercatori hanno condotto le indagini su campioni di:
– pelle di volontari
– modelli di pelle umana
imitando il morso della comune zecca dei boschi (Ixodes ricinus).
In entrambi i casi hanno verificato che la saliva delle zecche interrompe la funzione protettiva delle cellule immunitarie ospitate dalla pelle, favorendo la trasmissione dei microrganismi patogeni.
Cosa rivela la scoperta
Il morso di zecca altera il sistema difensivo cutaneo, impedendogli di svolgere l’effetto di barriera protettiva.
Studiando in particolare la Borrelia burgdorferi, il battere responsabile della Malattia di Lyme, il team di ricerca viennese ha dimostrato che la sua incubazione con estratti di saliva delle zecche impedisce l’accumulo di cellule immunitarie nel sito del morso.
In questo modo i batteri introdotti dalle zecche insieme alla saliva possono moltiplicarsi più facilmente e portare alla malattia.
Le altre indicazioni
Nello studio pubblicato sul The Journal of Clinical Investigation gli scienziati viennesi hanno inoltre sottolineato che:
– un’alta percentuale di zecche europee è infettata da agenti patogeni
– la malattia di Lyme e l’encefalite da zecche (Tbe) sono le più comuni malattie trasmesse dalle zecche
– basta una temperatura di sette gradi perché le zecche si attivino nella ricerca di un ospite sul quale alimentarsi
– a causa dei cambiamenti climatici le zecche rappresentano un’insidia quasi tutto l’anno, anche ad alta quota.
Per approfondire clicca qui
I ricercatori dell’università di Zurigo hanno scoperto un nuovo virus nelle zecche svizzere: si tratta dell’ Alongshan virus (ALSV), individuato per la prima volta in Cina nel 2017.
Appartiene alla stessa famiglia del virus della Tbe e provoca sintomi analoghi:
– febbre alta
– cefalea
– affaticamento.
Un problema emergente
Il virus è stato trovato in un’alta percentuale di zecche raccolte in diverse regioni della Svizzera nel 2021 e nel 2022.
Con sorpresa – ha dichiarato il Direttore dell’Istituto di virologia di Zurigo – il nuovo virus “è stato rilevato molto più frequentemente del virus dell’encefalite da zecca (Tbe).
Poiché entrambi causano sintomi molto simili “il virus Alongshan potrebbe già costituire un problema di salute pubblica in Svizzera, sebbene finora non riconosciuto”.
Un test diagnostico entro il 2023
Attualmente non esistono esami di laboratorio per rilevare l’infezione da Alongshan virus.
I ricercatori di Zurigo sono fiduciosi di poter sviluppare entro il 2023 un “test sierologico in grado di individuare l’infezione umana in campioni di sangue dei pazienti”. Con la disponibilità del test sarà possibile avere un quadro della situazione epidemiologica in Svizzera e monitorare anche la diffusione del virus nel territorio europeo.
Per approfondire clicca qui